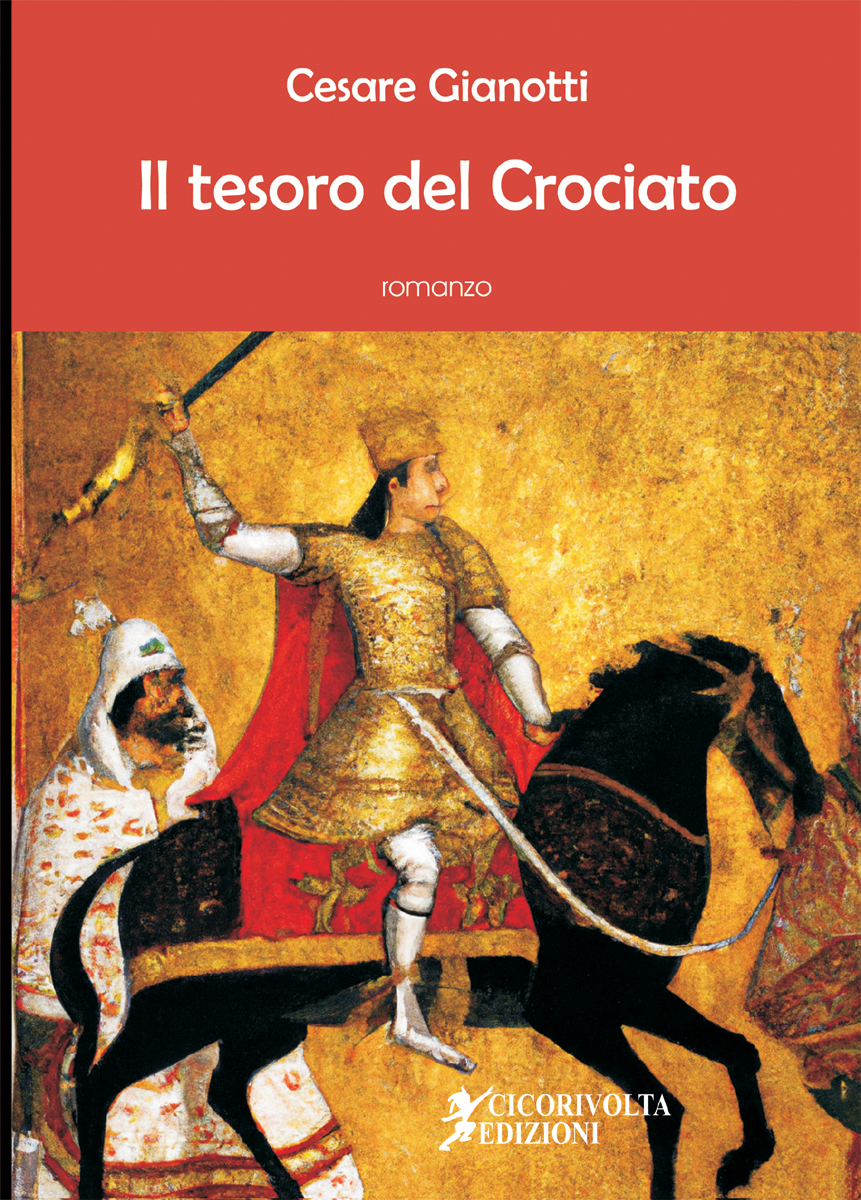titolo: "Il
tesoro del Crociato"
collana:Ciconauti
autore: Cesare Gianotti
ISBN 978-88-32124-49-1
€
18,00 - pp.252 -
© 2023 - in
copertina,illustrazione originale e progetto
grafico di Javier Guado.
Il romanzo riprende e conclude le vicende narrate ne "Il Crociato - La spada e l'usbergo". Mantenendo la stessa struttura, descrive a capitoli alterni gli eventi che vedono protagonisti, nel secolo XXI°, il giornalista Thierry Vidal, il suo collega Mansur Kouadiò, l'avvocato Alphonse Djallò e l'ex maggiore Mamadù Cissò; mentre, nel secolo XIII°, ancora una volta il cavaliere Cedric de la Riviere, divenuto principe di Ousmane, e il principe Yacubu Bello.
(continua)
![]()
(segue)
Un
antico manoscritto parzialmente bruciato rinvenuto a Timbuctù mette
Thierry Vidal sulle tracce del tesoro appartenuto al cavaliere de la Riviere
e mai ritrovato. In una regione del Sahara a cavallo fra Mali, Algeria
e Mauritania dove imperversano le varie fazioni dei fondamentalisti islamici
di Al Qaida, Thierry e i suoi amici, lasciata Timbuktù, si avventurano
alla ricerca del tesoro fronteggiando enormi e a volte drammatiche difficoltà.
Il duplice piano narrativo si sviluppa, nel XIII° secolo, attraverso
la spedizione condotta dal sultano del Marocco contro l'Impero del Mali
per impossessarsi delle miniere di sale nella sperduta località
desertica di Taghaza e con le fasi della sua eroica difesa ad opera dell'esercito
del Mali guidato dal principe Bello e da Cedric.
A
fare da sfondo alla narrazione è ancora una volta il deserto, con
le sue insidie, i suoi spettacolari tramonti e le sue lande desolate.
Brano tratto da: "Il
tesoro del Crociato"
PROLOGO
Precedute
dal signore del Marocco, il sultano Abu Yusuf Ya'kub ibn Abd al-Haqq,
imponente sul suo cavallo bianco e avvolto in un mantello di tessuto damascato
azzurro impreziosito da intricati ricami d'oro, le milizie marocchine
sfilavano lentamente sotto l'elegante arco a sesto acuto sovrastante la
porta meridionale della città di Sigjlmassa. Per l'occasione, erano
stati spalancati entrambi i battenti in legno massiccio decorati con grosse
borchie di bronzo, uno dei quali restava abitualmente chiuso.
Una folla plaudente le aveva accompagnate lungo tutto il percorso, dalla
piazza principale dove si ergeva la grande moschea recentemente imbiancata
a calce, sino alle massicce mura di pietra color ocra dove si apriva la
grande porta meridionale, e ora le salutava con alte grida di gioia e
ripetute invocazioni ad Allah il grande per una sicura vittoria. Erano
accompagnate dal suono acuto, simile a un ululato prolungato, della "zaghrouta",
emesso dalle donne nascoste dietro le "mashrabiye", i caratteristici
graticci in legno alle finestre.
Quando anche l'ultimo dei dromedari adibiti al trasporto delle salmerie
ebbe varcato la porta, le guardie si precipitarono a richiuderne i battenti,
mentre gli abitanti della città facevano lentamente ritorno alle
loro incombenze.
La spedizione contro la città di Taghaza, nel lontano impero del
Mali, era cominciata.
Non
era la prima volta che i regnanti del Marocco lanciavano una spedizione
militare contro quella remota località desertica, piccola per dimensioni
ma importante crocevia per il commercio del sale, ubicata a metà
strada fra i paesi dell'Africa settentrionale e quelli meridionali dell'impero
del Mali. Il prezioso minerale di cui abbondava il suo sottosuolo, da
secoli strategico per l'economia dell'impero assieme all'oro, all'argento,
all'avorio e al rame, veniva estratto in forma di lastre rettangolari
che, legate a coppie e caricate a due a due sul dorso dei dromedari, prendevano
la strada dei mercati settentrionali di Sijilmassa, nell'entroterra del
Marocco, e di Orano, sulle coste algerine del Mediterraneo, con interminabili
carovane che percorrevano le pericolose piste che attraversavano il deserto.
Ma anche quella dei mercati meridionali adagiati lungo le rive del grande
fiume, primo fra tutti quello di Timbuktù, antico insediamento
e già famoso centro religioso ai margini del deserto.
Due erano le carovaniere principali che dall'impero si dirigevano verso
il settentrione. La prima puntava, attraverso il grande deserto denominato
Erg Chech, verso l'oasi di Adrar, nell'Algeria meridionale, e la seconda,
più defilata, si dirigeva verso occidente, per raggiunger le oasi
del Marocco meridionale. Presentavano entrambe notevoli rischi, dovuti
alla precarietà dei rari punti d'acqua e alla presenza di estesi
cordoni di dune che, ripetendosi quasi all'infinito, costringevano le
carovane a frequenti cambi di direzione. Per non parlare poi delle temperature,
che anche nei periodi invernali potevano a volte arroventare l'aria, rendendola
soffocante.
Per questi motivi, di carovane non ne venivano organizzate più
di un paio all'anno, affidate a guide esperte e al comando di un capo
carovana, generalmente un commerciante di riconosciuta serietà,
in rappresentanza degli interessi di tutti i proprietari delle merci,
consorziati fra loro per ridurre i rischi. Una volta raggiunti i mercati
e vendute le merci, le carovane rientravano cariche di altri prodotti,
questa volte provenienti dalla penisola iberica, da quella italica e dal
medio oriente.
Sul fiorente commercio del sale, ma anche della polvere d'oro, dell'argento,
del rame e, non ultimo, quello degli schiavi, avevano da tempo gettato
gli occhi i sultani del Marocco, desiderosi di controllarne i mercati
carovanieri, fra cui, appunto, Taghaza, ben sapendo che avrebbero così
potuto imporre ai commercianti i loro dazi e ricavarne grandi vantaggi
economici con pochi sforzi. Ma, ogni qual volta avevano provato a impossessarsi
di Taghaza, erano sempre stati respinti con gravi perdite dagli uomini
di Mansa Uali, re di un vasto regno che si estendeva dalle coste del grande
mare, a occidente, sino alla regione orientale di Gao, il cui esercito,
negli anni, aveva raggiunto un invidiabile livello di organizzazione ed
efficienza.
Era l'impero del Mali.
Purtroppo, con la sua morte, si era scatenata una lotta per la conquista
del potere fra i due più alti dignitari di corte, lotta che aveva
sensibilmente indebolito la forza militare dell'impero, lasciandone sguarniti
i posti di frontiera a guardia dei confini. Proprio di questo intendeva
ora approfittare il sultano del Marocco, ritenendo maturi i tempi per
una definitiva conquista della piccola città mineraria.
CAPITOLO PRIMO
VALLE DELLA DRÀA
(MAROCCO MERIDIONALE)
OTTOBRE 1283
Sotto un sole che cominciava a far sentire i suoi fastidiosi effetti,
la colonna avanzava a passo lento percorrendo la carovaniera che conduceva
verso le regioni meridionali attraversate dal fiume Dràa, la cui
fertile valle era costellata di piccoli villaggi agricoli, in ognuno dei
quali il sultano Abu Yousuf intendeva reclutare un certo numero di uomini
destinati a ingrossare le fila delle sue truppe. Dietro il sultano, che
indossava un vistoso turbante di seta azzurra che ben si accompagnava
al mantello di identico colore, cavalcavano i generali nei loro abiti
dai colori decisamente meno appariscenti. Pochi i cavalieri, perché
la spedizione prevedeva l'attraversamento di vaste distese sabbiose che
sarebbero risultate d'impaccio per gli zoccoli di quei quadrupedi adatti
a terreni meno soffici. Nutrite, invece, le truppe a dorso di dromedario,
armate di scimitarra, pugnale e arco. E non mancavano quelle a piedi,
destinate a ingrossarsi nel corso della prima parte del viaggio, anch'esse
ben armate. Chiudevano la lunga colonna le salmerie, costituite da un
folto gruppo di dromedari per il trasporto delle vettovaglie, al momento
in gran parte scarichi. Solo più avanti, con la requisizione nei
vari villaggi delle derrate alimentari necessarie a uomini e animali,
sarebbero stati caricati di tutto punto prima di affrontare il deserto.
Il sultano arrestò il cavallo e alzò un braccio. A lui si
affiancò subito uno dei generali che, raccolto un suo ordine, tornò
indietro e indirizzò un comando verso la truppa. Un cavaliere,
uscito dai ranghi, si avvicinò lentamente e lo raggiunse. Pur indossando
anch'esso mantello e turbante, non portava addosso alcuna arma e il suo
aspetto tradiva l'appartenenza a una razza diversa. La sua pelle era infatti
di una tonalità decisamente chiara, ben diversa da quella leggermente
olivastra dei berberi che costituivano la quasi totalità degli
abitanti del regno. Anche la capigliatura, di un caldo color castano,
contrastava con quella nerastra e riccioluta dei berberi, che i cristiani
della vicina penisola iberica e dell'Andalusia in particolare, erano soliti
chiamare "mori".
Si trattava senza dubbio di uno straniero….
(…)
CAPITOLO SECONDO
TIMBUKTU (MALI)
LUGLIO 2012
Due ombre furtive, nel cuore di una notte senza luna, sgusciarono da una
stretta porta che si affacciava sul vicolo sabbioso che separava due fra
i più antichi quartieri della città. I due uomini, tenendosi
al riparo del muro di una bassa costruzione, si diressero verso la vicina
piazza sulla quale si affacciava l'antica moschea e da dove sembrava provenire
un tenue e intermittente chiarore. Giunti alla fine del muro si fermarono,
poi il primo si sporse con cautela oltre l'angolo per controllare la piazza.
Proprio davanti al portone spalancato della moschea di Sidi Yahia, edificata
nel XV secolo, ardeva un imponente falò le cui fiamme si innalzavano
irregolarmente, alimentate da una catasta di libri ammucchiati alla rinfusa.
L'uomo gettò uno sguardo tutt'attorno e, sinceratosi che non ci
fosse nessuno, abbandonò l'ombra protettrice e si precipitò
verso il rogo seguito dal compagno. Entrambi portavano sulle spalle due
ampi zaini vuoti che scaricarono presso la catasta ardente, poi, inginocchiatisi,
si misero a gettare manciate di sabbia che raccoglievano a piene mani
da terra, nel tentativo di spegnere le fiamme. In breve riuscirono a domare
il rogo; cominciarono allora a riempire gli zaini con i libri non ancora
aggrediti dal fuoco.
Si trattava di antichi manoscritti provenienti dal livello inferiore della
moschea, che ospitava una delle numerose e antiche biblioteche sparse
in tutti i luoghi di culto della città.
I manoscritti di Timbuktù, conosciuti in tutto il mondo, ormai
da diversi anni erano stati dichiarati dall'UNESCO Patrimonio dell'Umanità.
Sul loro numero i dati erano incerti, non essendone mai stato fatto un
vero censimento. Si parlava di circa settecentomila testi, molti ridotti
in condizioni pietose dall'usura dei secoli e dalla pessima conservazione,
e altri addirittura a un ammasso di fogli sciolti, rosicchiati dagli insetti
e dai topi. Di essi, circa ventimila erano stati catalogati e conservati
nei sotterranei del moderno Istituto di Studi Islamici, di recente realizzazione,
che prendeva il nome da Ahmed Baba, famoso studioso e scrittore islamico
contemporaneo di Shakespeare, ma moltissimi altri erano sparsi un po'
ovunque; sia nelle moschee della città che nelle abitazioni di
privati cittadini, le cui famiglie discendevano da coloro che, nel medioevo,
avevano ricoperto importanti cariche amministrative e politiche e che,
per amore del sapere, si erano creati le loro biblioteche personali. Ma
anche nelle case di gente di modeste condizioni, venutane in possesso
nel corso dei secoli, e, si mormorava, addirittura conservati in nascondigli
sotterranei fuori città, in pieno deserto, della cui ubicazione
erano in pochi a esserne a conoscenza.
(…)
I due uomini avevano quasi riempito i loro zaini quando un rumore di passi provenienti da una strada laterale li fece sussultare. Raccolsero il loro carico e si affrettarono all'interno della moschea, proprio mentre altri due uomini sbucavano nella piazza. Calzavano semplici sandali di plastica trasparente e indossavano una lunga camicia che gli scendeva alle caviglie, dal colore ormai indefinibile, ma che una volta doveva essere stata bianca. A tracolla portavano un kalashnikov e una borsa di tela piena di caricatori. Si avvicinarono al rogo, ormai quasi spento, e si guardarono perplessi. Dalla sabbia che ricopriva i manoscritti ormai inceneriti capirono che qualcuno era stato lì. Gettarono uno sguardo attorno, poi si precipitarono verso l'ingresso della moschea.
Appena
varcata la porta, i due uomini con lo zaino si erano trovati avvolti da
un buio totale. La notte era priva di luna e dalle poche e strette finestre
che si aprivano in alto, distribuite sui lati più lunghi di quell'ambiente
rettangolare che costituiva il corpo principale della moschea, sembrava
non penetrare alcuna luce. Questa era stata la loro prima impressione,
mentre a tentoni cercavano di avanzare. Ma, dopo pochi secondi, i loro
occhi avevano cominciato a scorgere delle ombre. In realtà l'ambiente
non era completamente buio; infatti dall'alto pioveva una debolissima
luce azzurra, il poco che riusciva a filtrare all'interno del chiarore
prodotto dalla volta celeste, animata da una moltitudine di stelle luccicanti.
Ombre immobili, verticali, che si materializzavano all'improvviso davanti
a loro, ostacolandoli nei movimenti. Erano le numerose colonne che sostenevano
il soffitto e che ora riuscivano a distinguere abbastanza bene. Si liberarono
degli zaini, nascondendoli dietro una di esse, proprio mentre i due uomini
armati facevano il loro ingresso e, a loro volta, si fermavano sorpresi
dal buio.
I due fuggitivi, intanto, muovendosi rapidamente e cercando di non far
rumore nel calpestare le stuoie che ricoprivano il pavimento di terra
battuta, si dirigevano verso il fondo, dove gli era parso di scorgere
una scala che scendeva. La raggiunsero nel momento in cui i loro inseguitori,
superato il primo momento di disorientamento, abituatisi a loro volta
al buio, cominciavano ad avanzare, senza sapere però dove dirigersi.
Si muovevano a caso attorno alle colonne, con precauzione per non andare
a sbattere, sinché non raggiunsero anche loro il fondo del vasto
ambiente e scorsero la scala. Gli altri, intanto, erano già giunti
in fondo ai gradini che immettevano in una stanza dal soffitto basso,
totalmente immersa nel buio. Nulla del debole chiarore dell'ambiente superiore
riusciva più a penetrare in quel sotterraneo. Capirono di essere
finiti in uno dei locali che costituivano la biblioteca quando, muovendosi
a tentoni, urtarono contro uno scaffale di legno su cui erano appoggiati
alcuni volumi. L'urto ne fece cadere uno, che piombò al suolo con
un rumore che, per quanto attutito dal pavimento di semplice terra battuta,
ai due, in preda a grande agitazione, parve spaventoso.
Si immobilizzarono, col cuore che gli martellava in petto.
A quel rumore gli inseguitori, che avevano già iniziato a scendere
i primi gradini, si arrestarono a loro volta, imbracciarono i kalashnikov
e fecero scattare la sicura con un suono secco, amplificato dai muri di
quell'ambiente angusto.
Uno dei fuggitivi afferrò il compagno per un braccio e mormorò,
in un soffio: "Non muoverti!".
Gli altri, intanto, giunti in fondo alla scala dove regnava un buio totale,
non si accorsero a loro volta della scaffalatura appoggiata al muro e,
maldestramente, la fecero cadere. Si udi un urlo, non di paura, ma per
incuterla, lanciato dal fuggitivo che aveva appena sussurrato all'amico
di non muoversi, a cui seguì un tramestio come di due corpi in
lotta fra loro, poi un grido che si strozzò in un lamento, accompagnato
da una raffica di kalashnikov i cui proiettili andarono a colpire il soffitto
in tutte le direzioni. Per una frazione di secondo gli spari illuminarono
l'ambiente. Il primo fuggitivo, quello che aveva ricevuto l'ordine di
non muoversi, scorse, a pochi centimetri dal suo, il volto stravolto di
uno dei due inseguitori, gli occhi sbarrati e la bocca spalancata, mentre
da uno squarcio della gola il sangue sprizzava a fiotti. Dietro di lui
intravide l'amico che stringeva in una mano un coltello insanguinato,
mentre con l'altra gli immobilizzava la testa. L'uomo appena sgozzato
imbracciava ancora l'arma da cui era partita la raffica. Come ultima cosa
intravide, presso la scala, il secondo inseguitore, quello che aveva fatto
cadere la scaffalatura, nell'attimo in cui, sorpreso dalla raffica, si
voltava verso i due avvinghiati, impugnando l'arma. Poi fu di nuovo buio.
Allora si buttò bocconi al suolo, mentre udì, vicinissimo,
un tonfo sordo e contemporaneamente il kalashnikov che aveva appena sparato,
non più trattenuto dall'uomo sgozzato piombato a terra, gli cadde
sulla testa. In preda al terrore lo afferrò, proprio mentre un'altra
raffica squarciava il silenzio. Udì i proiettili sibilare sopra
la testa e colpire, sbriciolandola, la scaffalatura più vicina
a lui prima di penetrare nel soffitto. Ci fu un altro lampo, ma, per l'infelice
posizione in cui si era venuto a trovare, non riuscì ad approfittarne.
Prontamente si rotolò su un fianco e, urlando per farsi coraggio,
lasciò partire a sua volta una raffica nella direzione in cui,
in base a quanto intravisto in precedenza, riteneva doversi trovare l'uomo
che aveva appena sparato. Continuò a sparare alla cieca, sempre
nella stessa direzione, finché non esaurì l'intero caricatore.
A ogni raffica un lampo illuminava la scena e così riuscì
a distinguere, in un frenetico alternarsi di luce e buio, il corpo dell'uomo
a cui aveva sparato incastrato in una scaffalatura contro cui era stato
scaraventato dalla violenza dei proiettili, crivellato di colpi e con
la testa quasi staccata dal corpo, ridotta a un irriconoscibile ammasso
sanguinolento. A terra, vicino a lui, giaceva il corpo coperto di sangue
dell'altro inseguitore e, nascosto sotto di lui, intravide l'amico che
l'aveva sgozzato e che l'aveva utilizzato come scudo protettivo. Scoppiò
a piangere, incapace di rialzarsi.
"E' tutto finito" disse l'amico, liberandosi del morto e mettendosi
in piedi. Poi lo prese per le spalle e lo costrinse a rialzarsi.
"E' tutto finito" ripeté, "alzati, dobbiamo andarcene
prima che arrivi qualcuno".
Ma l'altro, ancora sotto shock, non accennava a muoversi e l'amico dovette
afferrarlo per le spalle e guidarlo, al buio, verso i primi gradini della
scala. Quando furono di sopra recuperarono i loro zaini e uscirono all'aperto,
essendosi sincerati che fuori tutto fosse tranquillo. Dopo il buio del
sotterraneo la piazza parve loro luminosissima; per questo si infilarono
subito in un oscuro vicolo laterale.
(…)
Cesare Gianotti, nato a Ivrea nel 1940, dal
1946 al 1970 ha vissuto in Libia. Laureato in Scienze Geologiche, rientrato
dalla Libia, ha trascorso per lavoro sedici anni nell'Africa sub-sahariana,
di cui quattro in Costa d'Avorio e dodici in Nigeria. Vive quasi sempre
a Minorca (Baleari-Spagna). Ha pubblicato "Il Crociato - La spada
e l'usbergo" (prima edizione, Albatros 2011). Da Cicorivolta Edizioni
ha pubblicato i romanzi: “Una
storia siciliana (d’altri tempi)” (2013), “Prima
di morire”(2015), "Calma
piatta a Flamingos' Bay", "Il
Crociato - La spada e
l'usbergo"
(seconda edizione, 2023).