
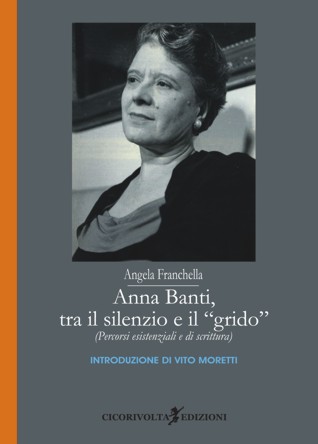
ordinalo senza spese di spedizione
... e di Angela Franchella leggi anche "L’Amore ritrovato - Esta vez será para siempre".
titolo:
"Anna
Banti, tra il silenzio e il grido. (Percorsi esistenziali e di
scrittura)" - Introduzione
di Vito Moretti.
autore Angela Franchella
ISBN 978-88- 97424-96-3
€
18,00 - pp.400
- © 2014.
Rilettura
critica dell'intera produzione bantiana.
Tra passione e violenza, tra buio e luce, tra presenza e assenza, tra arte e visione, tra voce e silenzio, si muove il flusso ininterrotto del sentire bantiano, la forza imperiosa e superba di un vissuto che stravolge la pagina, facendola grondare di inquietudini mai pacificate, di ossimori profondi e laceranti che frugano l'oscuro della coscienza riportandone in superficie relitti mai dissepolti in precedenza, lasciati lì, immobili e silenti, consegnati al lettore come istantanee, sottratti al magma del tempo e inchiodati sulla carta.
![]()
“Passione e violenza mi sembrano, a ragione, i due poli
verso cui tende la produzione bantiana, pur se ampliandosi a comprendere
al proprio interno una ben variegata gamma di sentimenti, dal silenzio
a-temporale della follia, (che spesso accomuna moltissime delle eroine
bantiane), fino a quella cieca perseveranza, mista di orgoglio e ostinazione,
che pure caratterizza i personaggi della scrittrice, portandoli spesso
sul baratro della nevrosi, (follia e testardaggine estrema sono dunque
strettamente legate, se non quasi “interscambiabili”, in questo
mondo a tinte fosche che la Banti ama tratteggiare integralmente nelle
proprie storie), dell'isolamento e perfino della morte, (laddove la
morte per la Banti non è solo intesa come fine ontologica del
proprio Esser-ci al mondo, ma anche, e soprattutto, come voluto e masochistico
autolesionismo distruttivo che, nell'agonia di giorni sempre identici
e a-significanti, spesso ingloba in un unico e terribile tempo mitico
e a-storico, dilatato all'infinito, le esistenze, miserevoli, di queste
anime di cartone, con cui pure la scrittrice pare soffrire compartecipando
al loro muto dolore). È dunque solo attraverso una rilettura
critica delle opere bantiane, che è possibile pervenire al fondo
della poetica della scrittrice, a quel grumo denso di ansie, insoddisfazioni,
dolori, lacrime, gioie e vittorie, che, in una sorta di memorabile testamento
spirituale, la scrittrice ha lasciato in eredità a noi, lettori
di ogni tempo”.
(Angela
Franchella)
Dall'Introduzione di Vito Moretti:
Anna Banti,
come altre della sua complessa stagione novecentesca, non è scrittrice
che si presti ad un approccio frettoloso ed ingenuo o ad un’analisi
convenzionale e di scorcio, per la cospicua significazione letteraria
dei suoi testi e per la vasta gamma delle problematiche ideali e storiche
che i suoi scritti recano al giudizio del lettore, oltre che per la pregnanza
dello stile, per la esemplarità dell’espressione e per i tratti
magistrali della scrittura, riconoscibili ancor più oggi, nella
frigida e sciatta ridondanza della letteratura contemporanea.
Personaggio, dunque, dai profondi dettati e dalle molteplici tramature,
fedele a un’idea di romanzo che impegna i labirinti della coscienza
e gli snodi dell’umano destino per una ipotesi di verità che
illumina gli orizzonti dell’essere, le oscurità che fanno
smarrire, i fuochi che sanno di mistero e le ostinazioni che hanno l’abito
del testamento e del dolore. E di tutto questo, per dote di sensibilità,
è ben consapevole Angela Franchella, scrittrice in proprio, che
affronta e ripercorre l’esperienza della Banti con la passione della
stessa autrice e con una strumentazione critico-filologica che, certo,
non è mancata ad altri interpreti, sia recenti che meno recenti,
ma che in lei ha il valore di una risorsa fruttuosa, di una modalità
conoscitiva con cui dar vigore, sulla pagina, a spunti riflessivi, a intuizioni
balenanti, a sintonie implicite, fino ad accompagnare il nostro sguardo
nei solchi tracciati dalle sue medesime parole e dalle sue stesse, acute
osservazioni: un percorso ermeneutico alacre e avvincente, che solo in
parte è riassunto dalla nota di premessa e che consegna, in realtà,
un profilo a tutto tondo della Banti, un’immagine della scrittrice
ancorata puntualmente ai suoi libri e alla cronologia dei suoi anni e
del suo lavoro, come pure alle tante incomprensioni che le impedirono
di spezzare la marginalità della sua presenza, in una società
sopita nei propri formalismi e nelle proprie angustie e per ciò
sorda a quel dire autentico e nuovo che le giungeva dalle opere bantiane,
a partire dalle prime prove, Itinerario di Paolina, del 1937, e
Il coraggio delle donne, del 1940, e soprattutto da Artemisia,
il cui manoscritto, perduto a Firenze nei frangenti della guerra e riscritto
a pace ristabilita, fu dato alle stampe nel ’47 proponendosi subito
come un vertice della geografia letteraria di allora e degli anni successivi,
eguagliato poi da altri romanzi e libri di racconti.
La Franchella, dunque, restituisce la scrittrice al suo ruolo di testimone
e di interprete di un bisogno di umanità e di giustizia che trovava
nelle donne, tradizionalmente sconfitte e tacitate, i soggetti di una
storia rarefatta di dolore e di violenza, di provocazioni e di ricatti,
di verità nascoste e di talenti traditi o rimossi; e ogni volta
ella coglie, nella narrazione della scrittrice, le ragioni autobiografiche,
le urgenze morali, i tratti di un’autocoscienza che si raccolgono
via via in un unico, ampio territorio, dove tutto sembra dilatarsi, lacerarsi
al di là del tempo, piegarsi ad un’agonia fisica e psicologica
e infine assumere, emblematicamente, quel “grido” che marca
l’ultimo titolo dei romanzi bantiani (Un grido lacerante,
1981); e così il femminismo, che pure conserva la sua tangibilità
realistica, si fa propriamente, nella lettura fornita da Angela Franchella,
umanesimo, vocazione a costruire la vita coniugando passato e futuro,
acquisto di forza e virtù, e mira – in ultima istanza –
a riannodare fili, a colmare lacune, a dar vita e legami a creature perdute
nel dramma della storia e nelle spoliazioni delle loro amare esistenze,
secondo una prospettiva che forse giunge alla scrittrice anche dalla sensibilità
e dall’impostazione “filosofica” di Roberto Longhi, suo
professore a Roma e marito dal gennaio del ’24: una intellettualità
che non sosta mai ai livelli superficiali e ritualistici dei fatti né
che si avvale – come i più – del senso comune, ma che
si fa occasione di approfondimento e tema di riscatto, di chiarezza e
di moderna disillusione, affinché il “brutto” non giunga
mai ad usurpare l’intero spazio della memoria, dei desideri e della
personale identità.
Per questi aspetti, la monografia di Angela Franchella va accolta come
un contributo fondamentale e come un’indagine che rimette legittimamente
in gioco, nell’orizzonte della nostra contemporaneità, l’esperienza
di una scrittrice dalla forza di rappresentare senza pari le ragioni di
una disubbidienza e di una alternativa alle scelte di gusto e ai presupposti
culturali ed estetici del romanzo di metà Novecento, con un vigore
di giudizio, peraltro, e con una argutezza critica che risultano formalmente
ineccepibili e persino ammirabili.
Angela
Franchella, nata a Ortona (Chieti), è laureata in Lettere a
pieni voti presso l’Università degli studi G. D’Annunzio.
Ha conseguito la specializzazione per l’insegnamento secondario presso
la S.S.I.S. “Raffaele Laporta” e un Master in Redazione Editoriale,
oltre ad aver frequentato vari corsi di perfezionamento attinenti la propria
classe di concorso; da sempre appassionata di letteratura, poesia e arte,
attualmente insegna materie letterarie presso l’Istituto Card. M.
Barbarigo a Roma, facendo convivere la passione per la scuola con un Amore
viscerale per la scrittura, intesa come profonda illuminazione e rivelazione
di Sé.
Scrittrice di poesie, narrativa e articoli, Angela Franchella ha pubblicato
la raccolta di poesie “Il sorriso del silenzio”, (Ennepilibri,
2007) e il romanzo “L’Amore ritrovato - Esta vez será
para siempre”, (Cicorivolta, 2012).